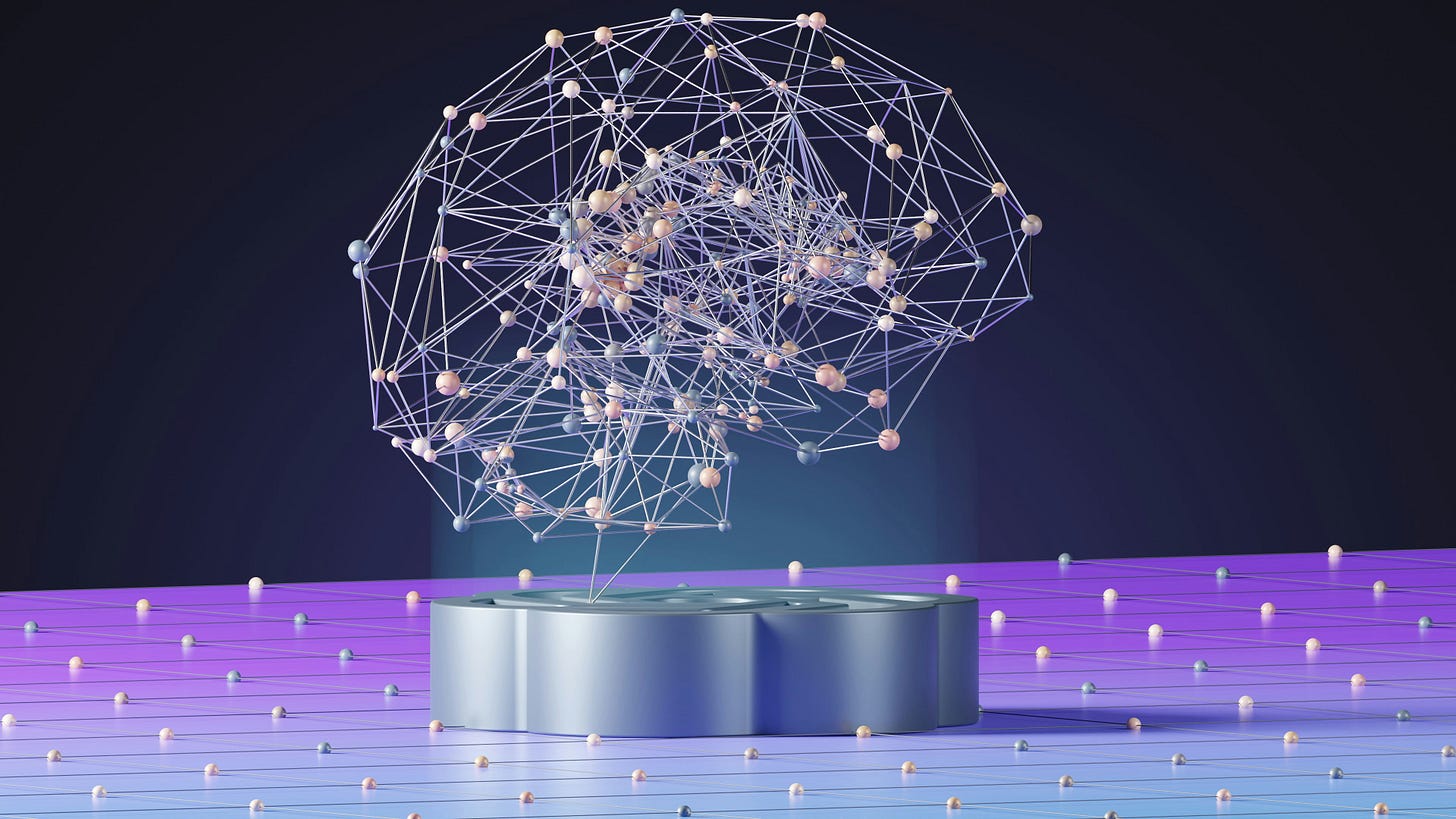🤖Cosa pensa un Fuoriclasse quando guarda all’Intelligenza Artificiale?
C’è un momento, nei mercati, in cui tutto sembra inevitabile. Oggi quel momento ha il nome di Intelligenza Artificiale.
Autori: Stefano Reali (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Riccardo Volpi (Portfolio Manager - Pharus Asset management S.A.), Andrea Guitta (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch), William Trevisan (Portfolio Manager - Pharus Management Lux S.A. - Milan Branch) | Persona Giuridica: Pharus Management Lux S.A. Sede di Milano | Autorità Competente: Banca D’Italia, CSSF | Raccomandazione Ultimata:27.10.2025 ore 12:00 | Prima diffusione della raccomandazione: 28.10.2025 ore 06:30 | Data e ora Prezzi: 27.10.2025 ore 12:00 | Informazioni secondo il Regolamento Delegato (UE) 2016/958 “Raccomandazione in materia di investimenti” sono a questo link.
Caro Fuoriclasse,
c’è un momento, nei mercati, in cui tutto sembra inevitabile. Oggi quel momento ha il nome di Intelligenza Artificiale.
Titoli ai massimi, capitali che scorrono senza sosta, entusiasmi che si alimentano a vicenda.
Ma mentre la folla corre, il Fuoriclasse osserva.
Non si lascia trascinare dall’euforia: misura, ragiona, attende. Sa che i mercati “surriscaldati” tornano sempre, con volti nuovi ma con gli stessi meccanismi di fondo — avidità, memoria corta, euforia collettiva.
L’AI è una rivoluzione autentica, certo, ma anche un terreno fertile per eccessi e illusioni.
E allora il Fuoriclasse si pone le domande che contano:
Cosa è reale e cosa è solo denaro che gira in tondo?
Quanto della crescita è sostenuto da vera domanda esterna?
E quanto invece da un ecosistema che vive di fiducia reciproca più che di profitto?
La risposta non è nei titoli del giorno, ma nella disciplina. Osservare i segnali, distinguere i cicli naturali dalle mode, ricordare che — nella finanza come nella vita — la pazienza batte sempre l’entusiasmo di massa.
È così che ragiona un Fuoriclasse.
E proprio mentre il mercato si infiamma per l’AI, si apre una finestra rara: tre aziende leader, oggi a sconto valutativo, offrono anche dividendi tra i più generosi del mercato.
Un binomio che combina valore e rendimento — equilibrio perfetto tra prudenza e opportunità. Ignorarlo significherebbe forse attendere anni per ritrovare occasioni simili. Perché il dividendo non è solo reddito: è ancoraggio alla realtà, un promemoria di ciò che conta davvero quando tutti inseguono la prossima “grande innovazione”.
Come ricorda Warren Buffett:
“Non devi essere una persona senza emozioni nella vita di tutti i giorni,
ma lo devi essere quando investi o prendi una decisione d’affari.”
Cominciamo!
1. Il déjà-vu dei mercati surriscaldati.
Come nota Jason Zweig del Wall Street Journal, stiamo assistendo al ritorno di molte vecchie conoscenze:
Le SPAC sono tornate: oltre 100 nuove emissioni nel 2025, per quasi 22 miliardi di dollari raccolti.
Le meme stock rialzano la testa: Opendoor Technologies +360% da inizio anno.
Perfino l’oro è salito del 65%, e nuovi ETF propongono leve 5x su titoli come Tesla o Bitcoin.
Gli ETF a leva sono esplosi negli ultimi anni. A metà ottobre, gli ETF mono-azionari con leva finanziaria avevano accumulato circa 40 miliardi di dollari di asset, secondo i dati VettaFi. Gli ETF con leva finanziaria incassano in genere circa l’1% sugli asset che gestiscono, ben al di sopra della commissione media dello 0,3% dei fondi attivi. Secondo gli analisti di Bank of America, solo nel 2025 sono stati lanciati circa 200 ETF azionari con leva finanziaria, portando il numero totale a 701 fondi a ottobre.
Infine il tema AI, che rappresenta da un lato il futuro e la rivoluzione tecnologica, ma dall’altro può dare vita a euforie. L’intelligenza artificiale è una rivoluzione tecnologica autentica, ma anche le rivoluzioni seguono le leggi dell’economia: nessun ciclo di crescita può sostenersi solo su sé stesso. Quando gli investimenti, le partecipazioni e i ricavi diventano parte dello stesso circuito chiuso, il rischio è che la creazione di valore reale venga sostituita da una bolla di fiducia reciproca.
E la domanda che sorge spontanea è: come mai se ne parla sempre poco? Semplice, siamo nel momento dell’euforia. E il Fuoriclasse deve sempre cercare in modo razionale di capire in che momento si è.
2. Le anomalie che stanno nascendo nel settore dell’intelligenza artificiale
Negli ultimi mesi sta emergendo una dinamica anomala nel mondo dell’intelligenza artificiale, che alcuni investitori definiscono “circolarità”.
Il termine descrive un meccanismo pericolosamente diffuso: le stesse aziende si finanziano e si sostengono a vicenda, creando una rete di dipendenze che può amplificare la crescita — ma anche i rischi di crisi.
Negli anni Duemila lo si chiamava vendor financing: i fornitori concedevano credito ai clienti per permettere loro di acquistare i propri prodotti. Oggi la logica è simile, ma avviene su scala molto più ampia e sofisticata.
Cos’è il “finanziamento circolare”
Il concetto è semplice: una società investe in un’altra, che a sua volta utilizza quei fondi per acquistare prodotti o servizi della prima.
Il flusso di capitale gira in tondo, gonfiando ricavi e valutazioni senza un corrispondente incremento di valore reale.
Negli anni ’90, colossi come Lucent Technologies concedevano credito ai clienti (spesso startup) per comprare le loro infrastrutture di rete. Quando quei clienti fallivano, anche i fornitori subivano perdite miliardarie.
Oggi lo stesso schema riappare nel cuore della rivoluzione AI.
La nuova circolarità nell’era dell’AI
Un caso emblematico è la partnership tra Nvidia e OpenAI:
Nvidia ha annunciato un investimento fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI.
OpenAI, a sua volta, utilizza parte di quei fondi per acquistare milioni di chip Nvidia.
Formalmente non si tratta di un prestito, ma la dinamica è circolare: Nvidia finanzia un cliente che sostiene la sua stessa crescita.
Per alcuni è una sinergia industriale; per altri, un ciclo autoalimentato che funziona solo finché i capitali continuano a fluire.
E questo è solo un tassello di un intreccio molto più complesso.
Una rete di dipendenze incrociate
Secondo un’analisi di Morgan Stanley, i rapporti finanziari tra Nvidia, Microsoft, OpenAI, Oracle, AMD e CoreWeave ricordano “un piatto di spaghetti”.
Ecco alcuni esempi:
OpenAI ha firmato un contratto da 300 miliardi di dollari con Oracle per servizi cloud nei prossimi cinque anni. Ma resta incerto come potrà finanziarlo se l’investimento di Nvidia non si concretizzerà.
AMD, per attirare OpenAI come cliente, ha concesso warrant che consentono di acquistare fino al 10% delle proprie azioni a prezzo simbolico.
CoreWeave, specializzata in infrastrutture cloud per l’AI, è partecipata da Nvidia (5%), compra chip Nvidia e allo stesso tempo vende capacità di calcolo proprio a Nvidia — fino al 2032.
Microsoft è investitore in OpenAI, ma anche cliente di CoreWeave; e OpenAI è a sua volta azionista di CoreWeave.
Il risultato è un intreccio finanziario e operativo talmente fitto da rendere difficile distinguere le vere relazioni industriali dai flussi puramente finanziari.
Fiducia come carburante del sistema
Queste relazioni non sono illegali né necessariamente tossiche.
Servono a finanziare rapidamente l’enorme infrastruttura necessaria per sostenere l’espansione dell’AI generativa.
Tuttavia, la circolarità è virtuosa solo finché la fiducia regge.
Se gli investitori iniziassero a dubitare della redditività di lungo periodo, il sistema potrebbe bloccarsi di colpo: la dipendenza reciproca che amplifica la crescita in fase espansiva amplificherebbe anche le perdite in fase di contrazione.
È uno schema pro-ciclico: funziona in salita, crolla in discesa.
L’intreccio strategico costruito da Sam Altman
Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha costruito una rete di alleanze che lega tra loro i giganti tecnologici globali: Nvidia, AMD, Broadcom, Oracle e SoftBank.
Tutto parte quando OpenAI lascia intendere di voler ridurre la dipendenza dai chip Nvidia, valutando i chip TPU di Google.
In risposta, il CEO di Nvidia Jensen Huang corre a chiudere un accordo da 100 miliardi di dollari con OpenAI per blindare la partnership.
Altman però continua a tessere la rete:
firma un contratto quinquennale con AMD, che prevede la possibilità di acquisire fino al 10% del suo capitale;
coinvolge Broadcom nella produzione di chip personalizzati;
integra Oracle e SoftBank in un maxi-accordo da 300 miliardi di dollari per capacità cloud.
Il risultato è chiaro: tutti i grandi attori dell’hardware e delle infrastrutture digitali sono oggi finanziariamente esposti al destino di OpenAI.
Se OpenAI cresce, tutti guadagnano.
Se inciampa, tutti perdono.
Altman ha trasformato la paura di restare indietro (FOMO, Fear of Missing Out) in un’arma industriale, rendendo OpenAI un pilastro dell’intero ecosistema tecnologico globale.
Ma un pilastro così interconnesso è anche una fonte di rischio sistemico.
Le principali criticità finanziarie emergenti
L’analisi di Morgan Stanley e altri osservatori individua quattro rischi chiave legati a questa circolarità:
Round-tripping o vendor-financing nascosto
Quando una società A investe in B, che poi compra prodotti di A, i ricavi risultano gonfiati artificialmente. Il confine tra vendita reale e finanziamento del cliente diventa sempre più sottile.Indebitamento o “OPA del bilancio” nascosto. Gli investimenti incrociati tramite equity, warrant o prestiti collegati possono mascherare la reale redditività.
Spesso ciò che appare come ricavo da vendita è solo lo stesso denaro che gira all’interno del sistema.Concentrazione dei rischi e dipendenze reciproche
Quando le aziende sono legate finanziariamente e operativamente, il fallimento di una può trascinare le altre. L’intero ecosistema diventa fragile e vulnerabile.Scarsa trasparenza e “AI washing”. Alcune aziende dichiarano grandi progetti di intelligenza artificiale senza rendicontare in modo chiaro i flussi di cassa o la reale origine dei ricavi.
La SEC americana ha già sanzionato società che affermavano di usare l’AI senza farlo realmente.
I segnali da monitorare per gli investitori
Per individuare situazioni di potenziale circolarità, è utile osservare:
flussi di acquisti e vendite tra aziende correlate che sembrano sostenere i ricavi più che generare vera domanda esterna;
investimenti incrociati o accordi poco chiari sui ritorni economici;
margini stagnanti nonostante la forte crescita delle vendite;
bilanci che rivelano clienti che sono anche investitori o partner con contratti futuri predefiniti;
forte concentrazione su pochi clienti o fornitori chiave;
crescente richiesta dei regolatori di maggiore trasparenza su rischi e modelli di business legati all’AI.
In conclusione, il boom dell’intelligenza artificiale sta costruendo un’economia interconnessa e autoreferenziale, dove i giganti si finanziano e si sostengono a vicenda.
È un capolavoro strategico, ma anche un potenziale rischio sistemico.
Come in ogni bolla alimentata da entusiasmo e capitale abbondante, la domanda chiave resta una:
quanto di questa crescita è reale — e quanto è solo denaro che gira in cerchio?
Detto questo, il Fuoriclasse sa che l’AI porterà nell’industria una rivoluzione al pari di Internet degli anni 90’.
Ma come Internet ha fatto vincitori e vinti, anche la guerra dell’AI farà lo stesso.
E quindi un Fuoriclasse che dovrebbe fare?
Come sempre tornare alle basi. Cioè aziende leader a sconto valutativo. Ed oggi è possibile selezionare questa tipologia di azienda anche con un ottimo dividendo.
Perché tornare ai dividendi?
Ci sono momenti nei mercati in cui la fortuna bussa piano — e questo è uno di quelli. Oggi, infatti, molte aziende leader si trovano a sconto valutativo e, al tempo stesso, offrono dividendi elevati. Un’occasione rara: non capita spesso che qualità e rendimento si incontrino nello stesso titolo. E non coglierla significherebbe forse dover attendere altri cinque anni prima di ritrovare prezzi interessanti su società con fondamentali solidi e politiche di distribuzione generose.
Ma perché il dividendo è così importante?
Perché rappresenta una difesa naturale dal rischio. In un mondo dove i mercati corrono dietro all’ultima moda, il dividendo è ciò che riporta l’investimento alla realtà, all’economia vera, ai flussi di cassa che contano davvero.
Certo, non tutte le aziende devono pagarlo — pensiamo al settore tecnologico, dove la priorità è spesso reinvestire per crescere. Ma proprio oggi, in un momento di euforia collettiva sull’intelligenza artificiale, in cui le imprese spendono miliardi per non restare indietro nella corsa tecnologica, il Fuoriclasse deve saper fare il contrario: fermarsi, uscire dal gregge, e sedersi sulla riva del fosso ad aspettare.
Aspettare, sì — ma in modo intelligente. E questo significa investire su leader solidi, sottovalutati e con dividendi generosi: aziende che continuano a creare valore anche quando il rumore del mercato si spegne.
Vediamone tre insieme:
🏭Azienda 1
C’è una grande azienda globale che sta attraversando una trasformazione profonda.
Dopo anni di riorganizzazioni, scelte strategiche e operazioni straordinarie, oggi concentra tutte le energie su pochi segmenti ad alto potenziale.
La sfida, però, è tutt’altro che semplice: la crescita rallenta, la concorrenza si intensifica e il peso di alcuni cicli industriali in scadenza si fa sentire.
Per difendere la redditività, il management ha varato un piano di efficienza multimiliardario, reinvestendo parte dei risparmi per rafforzare le aree più innovative e garantire un vantaggio competitivo nel lungo periodo.
Il risultato è una storia di transizione e resilienza, dove la disciplina finanziaria si intreccia con la capacità di reinventarsi in un contesto globale sempre più competitivo.
Abbonati per vedere la versione completa dove analizziamo numeri, strategie e prospettive di questa società leader che, ancora una volta, sta provando a reinventare il proprio futuro.
🏭Azienda 2
C’è un gigante globale che per anni ha incarnato l’efficienza operativa e la forza industriale.
Oggi, però, si trova nel pieno di una trasformazione complessa, costretto a ripensare il proprio modello per difendere i margini in un contesto in rapido cambiamento.
Negli ultimi anni, l’azienda ha scelto di ridurre la dipendenza da un grande cliente strategico, sacrificando parte dei volumi per migliorare la redditività futura. Una mossa necessaria, ma che nel breve ha pesato su ricavi e utili.
A complicare lo scenario si aggiungono costi del lavoro più elevati, flussi internazionali in contrazione e una pressione crescente sulla generazione di cassa.
Il management ha risposto con un piano di efficienza da miliardi di dollari, fondato su automazione, ristrutturazioni e una nuova disciplina finanziaria.
Nonostante le difficoltà, la leadership resta convinta della solidità dei fondamentali e difende una politica di remunerazione agli azionisti che molti considerano un simbolo di forza e credibilità.
Abbonati per vedere la versione completa dove analizziamo come questo gigante globale sta cercando di ritrovare equilibrio tra stabilità, innovazione e sostenibilità finanziaria — e perché il mercato potrebbe starlo sottovalutando.
🏭Azienda 3
C’è un gruppo internazionale che ha costruito la propria forza non sulla quantità, ma sulla qualità percepita.
Negli ultimi decenni ha saputo crescere attraverso acquisizioni mirate, consolidando un portafoglio di marchi iconici riconosciuti in tutto il mondo.
La sua strategia è chiara e coerente: meno volume, più valore.
Invece di inseguire la crescita a tutti i costi, punta a elevare i propri prodotti nella fascia premium, intercettando un trend globale ormai strutturale: consumare meno, ma meglio.
La sua presenza capillare nei mercati emergenti e la forza dei brand storici gli consentono di mantenere margini elevati anche nei momenti di debolezza ciclica.
Questa società unisce scala globale, pricing power e disciplina finanziaria, elementi rari da trovare nello stesso modello industriale.
Nonostante le sfide regolamentari e i cambiamenti delle abitudini dei consumatori, continua a generare ritorni costanti e a difendere la propria leadership con una resilienza che pochi possono imitare.
Abbonati per vedere la versione completa dove analizziamo strategie, vantaggi competitivi e prospettive di rivalutazione di questo campione silenzioso, oggi scambiato a forte sconto rispetto al suo valore intrinseco.